ALBERT CAMUS, La peste
PADRE PANELOUX: DALLA PRESUNZIONE ALL’UMILTA’

Tra le opere letterarie tornate drammaticamente di attualità, si trova il romanzo La peste, di Albert Camus, pubblicato nel 1947, all’indomani della conclusione del secondo conflitto mondiale.
Orano, la località algerina in cui la vicenda è ambientata, viene messa in quarantena e le sue autorità vivono il dramma delle decisioni da assumere per evitare il contagio. I commercianti, angosciati, si trovano costretti ad interrompere le loro attività e uno tra essi si arrende e sceglie il suicidio; tra gli abitanti si diffondono preoccupazione ed inquietudine e tutti assistono ad un incredibile aumento dei contagi. Le manifestazioni della malattia evolvono e, dalla forma bubbonica, assumono quella della congestione polmonare. I medici cercano un “siero” capace di debellare il flagello, mentre si susseguono congetture sulle cause e sui rimedi.
Angosciosa sopra ogni altra cosa si mostra l’immagine della quantità dei cadaveri, con il problema della loro sepoltura. I morti sono trattati alla stregua di “cose” che hanno smesso di funzionare, come esseri privati della pur minima dignità, dopo aver chiuso violentemente la loro esistenza. I vincoli di parentela, i legami sociali, la dimensione comunitaria si dissolvono di fronte alla paura del contagio e a contatto con un evento dall’immensa portata distruttiva.
Un passo dell’opera serve a dare l’idea dello scenario sullo sfondo del quale si muovono, riflettono, reagiscono i personaggi:
Nonostante il successo dell’amministrazione, il carattere sgradevole che vennero ad assumere le formalità costrinse la prefettura a tener lontani i parenti dalla cerimonia. Si tollerava soltanto, e nemmeno ufficialmente, che venissero alla porta del cimitero. Infatti, riguardo all’estrema cerimonia, le cose erano un po’ mutate. In fondo al cimitero, in un terreno nudo, coperto da lentischi, si erano scavate due immense fosse; c’era la fossa degli uomini e quella delle donne. Da questo punto di vista, l’amministrazione rispettava le convenienze e soltanto molto più tardi, per forza di cose, quest’ultimo pudore scomparve, e si seppellì alla rinfusa, gli uni sulle altre, uomini e donne, trascurando la decenza. Per fortuna, quest’ultima confusione contraddistinse unicamente i momenti estremi del flagello. Nel periodo di cui ci occupiamo la separazione delle fosse esisteva, e la prefettura ci teneva molto. In fondo a ognuna un grosso strato di calce viva fumava e bolliva. Sugli orli della buca una montagnola della stessa calce lasciava scoppiare le sue bolle all’aria aperta. Quando i viaggi dell’ambulanza erano terminati, si portavano le barelle in corteo, si lasciavano scivolare nel fondo, press’a poco gli uni accanto agli altri, i corpi spogliati e leggermente contorti; li si coprivano di calce viva, poi di terra, ma sino a una certa altezza soltanto, allo scopo di preparare il posto ai futuri ospiti. Il giorno dopo i parenti erano invitati a firmare in un registro, il che segnava la differenza più importante che ci può essere tra gli uomini e, ad esempio, i cani: il controllo era sempre possibile.
Eppure qualcosa di profondo si muove nella riflessione di alcuni personaggi, di quelli che non cedono alla cruda realtà, al cinismo della situazione. Il disfacimento di ciò che può dirsi veramente e profondamente umano non è totale.
C’è spazio per altro, per una riflessione che vada oltre e che sia umanamente significativa.
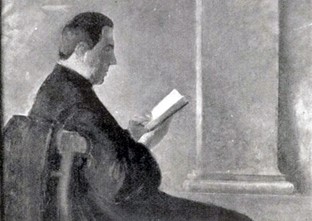
È ciò che accade nell’animo di uno dei personaggi chiave della vicenda. Si tratta di Padre Paneloux, sacerdote gesuita, persona colta e di grande spessore, conosciuto e stimato in tutta Orano, un religioso dalla solida cultura teologica che lo rende sicuro di poter offrire risposte puntuali e indiscutibili a qualsiasi problema.
La peste comincia a mietere le prime vittime. E padre Paneloux pronuncia la sua prima predica.
Fratelli miei, voi siete nella sventura, fratelli miei. Voi lo avete meritato.
La prima volta che il flagello appare nella storia, è per colpire nemici di Dio. Faraone si oppone ai disegni eterni e la peste, allora, lo fa cadere in ginocchio. Dal principio d’ogni storia, il flagello di Dio mette ai suoi piedi gli orgogliosi e gli accecati. Meditate e cadete in ginocchio.
La peste è un flagello di Dio, è la diretta ed immediata punizione divina in risposta al male causato dagli uomini.
Spiegazione immediata che tuttavia si rivela inefficace e anche eccessivamente semplicistica.
Nei sette mesi che seguono il contagio non risparmia nessuno: uomini e donne, persone ragguardevoli e semplici cittadini, buoni e cattivi. Iniziano a morire anche i bambini.
Paneloux stesso avverte che la sua spiegazione è insufficiente, addirittura blasfema. “Come è possibile – grida al sacerdote il dottor Rieux, medico degli appestati – come è possibile amare questa creazione in cui i bambini sono torturati?”.
Arriva il giorno in cui il buon sacerdote si trova davanti ad un bambino divorato dalla peste. Cade in ginocchio e, con voce strozzata, mormora tra sé: “Mio Dio, salva questo ragazzo!”. Il ragazzo muore e i singhiozzi di dolore che si diffondono coprono la preghiera di Paneloux che entra in crisi. Inizia a porsi interrogativi sempre più profondi. Il tormento si fa spazio nel suo animo, fino ad allora troppo incline alle risposte semplicistiche.
E arriva il giorno della sua seconda predica. Egli sale sul pulpito e il suo atteggiamento si fa umile. Non si rivolge più ai fedeli con il “voi”, ma dice: “noi”.
Inizia la sua predica e via via il suo tono si fa fermo, ma non superbo. Ricorda i lunghi mesi di peste e tutti i lutti che il flagello ha seminato.
Afferma che ci sono cose che si possono spiegare riguardo a Dio e altre che non si possono capire. Che riguardo al male non si può spiegare la sofferenza di un bambino innocente. Che non c’è nulla di più importante della sofferenza d’un bambino e dell’orrore causato dalla sofferenza innocente. Si esprime così:
“Fratelli miei, il momento è venuto. Bisogna tutto credere o tutto negare. E chi mai, tra di voi, oserebbe tutto negare?”
“Fratelli miei, l’amore di Dio è un amore difficile: suppone un totale abbandono di se stessi e il disprezzo per la propria persona. Ma lui, solo può cancellare la sofferenza e la morte dei bambini, lui solo in ogni caso può renderla necessaria, in quanto è impossibile capirla e non si può che volerla. Ecco la difficile lezione che volevo dividere con voi; ecco la fede, crudele agli occhi degli uomini, decisiva agli occhi di Dio, a cui bisogna avvicinarsi”.
La dignità dell’uomo sta certamente nell’interrogarsi,
ma essa si esprime, nella sua forma più alta, attraverso la capacità di affidarsi.
Non si tratta di trovare facili consolazioni e neppure buone illusioni,
ma di mirare ad un orizzonte più ampio e più vero,
capace di dare senso a ciò che accade,
di orientare una ricerca che non può non approdare,
di illuminare una strada che non può rimanere senza uscita,
capace, infine, di superare il baratro dell’assurdo in cui non possiamo cadere.
Il nulla non esiste, il non essere non può essere;
l’uomo non può non rispondere agli interrogativi di senso che si affacciano al suo cuore.
Ecco: il cuore è il luogo della ricerca,
il cuore che ha come unica esigenza due braccia spalancate alle quali affidarsi.
Domenico Vescia