CARPE DIEM: COGLI L’OGGI PER AVERE SAPORE
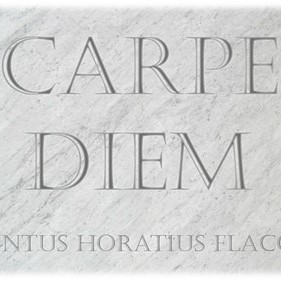
Due parole - un verbo al modo imperativo e un nome - che formano un’espressione tra le più bistrattate (e fraintese) della letteratura latina.
Si tratta del "carpe diem", un ammonimento contenuto nell'ultimo verso - l’ottavo – dell’undicesimo Carme delle Odi del grande poeta latino Orazio, vissuto tra il 65 e l’8 a.C.
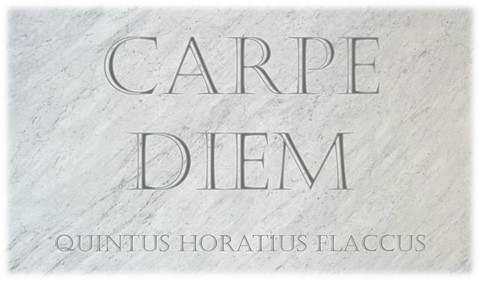
"Cogli l'attimo": questa la traduzione maggiormente proposta, ma anche più fuorviante.
C’è chi ha fatto diventare il “carpe diem” una sorta di manifesto del disimpegno, come se l’espressione equivalga a non prendere troppo sul serio la vita, perché non si può sapere cosa riserverà il domani. C’è anche chi ne ha fatto una massima per gaudenti, un suggerimento a godere dei piaceri della vita, senza troppi scrupoli. C'è addirittura chi ha visto in Orazio un precursore (e magari un ispiratore) di Lorenzo il Magnifico che, ne Il trionfo di Bacco e Arianna, ripete continuamente: "chi vuol esser lieto sia" poiché “di doman non v'è certezza".
Il vertice del fraintendimento è rappresentato da un noto film del 1989, L’attimo fuggente, che propone un Orazio che invita all’esagerazione, alla ribellione nei confronti delle consuetudini e dei valori acquisiti, alla libertà e all’originalità ad ogni costo.
In realtà, a ben guardare (e a ben comprendere) quello di Orazio è un monito di grande spessore morale, prezioso per tutti coloro che vogliono realizzare il bene per la propria esistenza.
Per comprendere a fondo il messaggio del poeta latino, occorre mettere le due preziose parole in relazione a quattro espressioni chiave del testo.
È significativo innanzitutto che Orazio si rivolga ad una persona ideale di nome Leuconoe che, nella sua derivazione greca, significa “fanciulla dalla mente candida”. Ciascuno può essere Leuconoe, avere la mente candida, se si interroga su quale sia l’atteggiamento – mentale, emotivo e intellettuale – più corretto per affrontare con pienezza la propria esistenza.
Nei primi due versi Il poeta suggerisce a se stesso e a Leuconoe di “non chiedersi, dal momento che non è lecito sapere, quale fine gli dei abbiano assegnato” [Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi / finem di dederint (vv. 1 e 2)], neppure – come affermerà subito dopo – consultando gli astri.
Non c’è un destino che ci sovrasta – potremmo dire parafrasando il poeta – ma c’è un presente da vivere attraverso occasioni da cogliere.
Ma la chiave è offerta da tre imperativi che il poeta propone ai versi 6 e 7.
Il primo: sapias (v. 6). “Sii saggia”: dice Orazio a Leuconoe, con il congiuntivo esortativo del verbo sàpere. Per capire è necessario considerare che tale verbo significa sia “aver sapienza”, sia “avere sapore”. Sii saggia allora significa: sii sapiente, ma anche abbi sapore. Ciò che il poeta chiede è di dare sapore alla vita, di rendere la propria esistenza ricca di motivi per vivere bene.
Subito dopo, con una splendida immagine, Orazio esorta Leuconoe: vina liques (v.6), filtra il vino!
Egli allude all’operazione di filtraggio del vino come si usava nell’antichità, quando lo si faceva passare attraverso una stoffa pere eliminarne le impurità. Per comprendere è fondamentale considerare ciò che il vino simboleggia nell’immaginario antico: la gioia. Orazio stimola la sua interlocutrice a togliere dalla propria vita tutti i motivi che le impediscono di assaporare la gioia.
Da ultimo, l’espressione spatio brevi spem longa reseces (vv. 6 e 7), che potremmo tradurre così: taglia la speranza lunga dal tempo breve. Ciò che il poeta suggerisce è di giocare nell’oggi ciò che è bene per la propria vita. Se rimandi a domani ciò che è bene per te – sembra dire Orazio – non lo realizzerai mai. Impegnati, invece, nell’oggi, fai in modo di dare il meglio di te, nel momento e nell’occasione che ti è offerta qui e adesso!
Solo dopo queste tre esortazioni, Orazio propone il proprio imperativo: “Mentre parliamo – afferma – sarà fuggito avido il tempo” … e allora: “Carpe diem”!
Afferra l’oggi per dare il massimo di ciò che sei capace,
per impegnarti in vista della tua realizzazione,
per guardare con realismo il tempo che ti è dato e per valorizzarlo, nella consapevolezza che non è infinito,
per cogliere le occasioni di crescita,
per diventare pieno di sapienza e di “sapore”,
per costruire la tua felicità.
Domenico Vescia